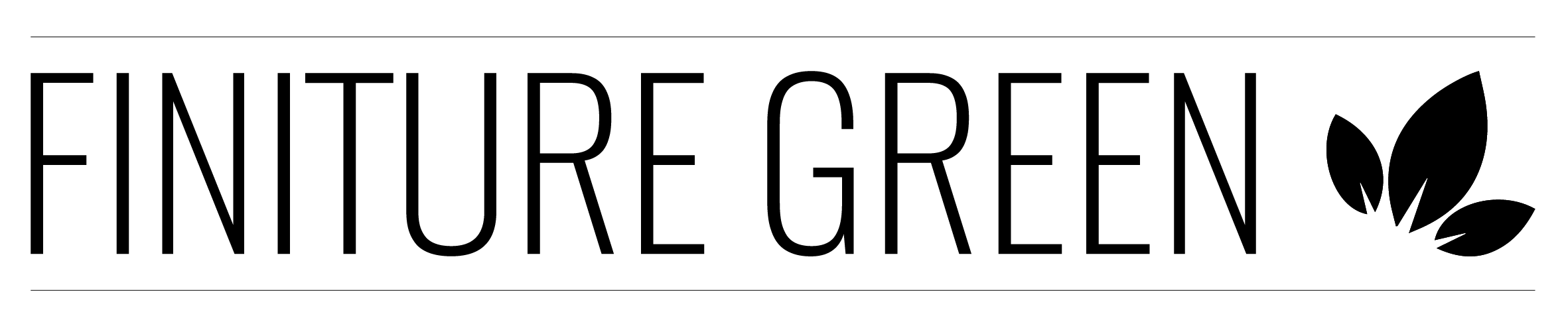Alle radici del design italiano con Emanuela Frattini Magnusson
Intervista a Emanuela Frattini Magnusson
Emanuela Frattini porta un nome importante che rimanda immediatamente al design che ha reso il Made in Italy ciò che ancora oggi celebriamo. A lei abbiamo chiesto di farci fare un salto nel passato e nel futuro, partendo dalla mostra “Gianfranco Frattini, ieri, oggi, domani” dedicata allo straordinario lavoro creativo di suo padre e ospitata nella sale di Palazzo Borromeo a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Facciamo un salto indietro nel tempo, come viveva suo padre Giancarlo Frattini il rapporto con il territorio, con gli artigiani e con le aziende?
Mio padre si è trovato a lavorare in Brianza, un territorio di straordinaria ricchezza fatto di artigiani e dove, ai tempi in cui era attivo mio padre e soprattutto agli inizi della sua carriera – alla fine degli anni ’50 – non esisteva CAD o la stampa 3D. I progetti si verificavano in bottega e non a caso lui spesso diceva: “come progettista io sono nato in bottega perché le mie idee le verifico con quelli che sanno fare le cose, oltre a immaginarle e pensarle poi bisogna anche saperle fare”. Mio padre dava molta importanza al lavoro manuale mettendolo sullo stesso piano di quello concettuale e creativo; lui vedeva gli artigiani e i produttori come collaboratori del processo produttivo.
Possiamo dire che nell’elaborazione dei progetti da parte di suo padre è stato fondamentale l’aspetto collaborativo e il saper fare degli artigiani?
Assolutamente sì. Questo è sicuramente un lascito del lavoro che aveva fatto nello studio di Gio Ponti, che esercitava la professione a tutto raggio. Gli architetti e designer del tempo si confrontavano in progetti che passavano dall’edificio, all’interno, fino all’oggetto di arredo. Il loro processo era basato sullo sviscerare i dettagli costruttivi ed estetici per i quali bisognava studiare le cose mettendoci mano, realizzando modelli direttamente in bottega con operai, falegnami, ebanisti e modellisti.
C’è stato un periodo in cui questo processo si è un po’ perso o suo padre è riuscito comunque in tutta la sua attività a mantenere un collegamento stretto con la produzione?
Mio padre ha sempre avuto un suo modo di lavorare; non si è mai inquadrato intenzionalmente in una scuola o corrente. Si sentiva culturalmente parte del razionalismo italiano e non in tendenze più brevi o estetistiche. Lui faceva quello che riteneva giusto. Parlando di materiali, credeva fondamentale utilizzarli secondo la loro propria natura, esaltandone le qualità intrinseche. Il suo prediletto era il legno e da questo amore è nato il legame con la Brianza e i suoi personaggi, primo fra tutti il maestro ebanista e amico fraterno Pierluigi Ghianda. Cosa possa essere adatto o meno per certe lavorazioni lo si impara davvero quando si mette mano al materiale. Si impara con l’esperienza, frutto di collaborazioni che durano decenni.
Facciamo ora un salto nel presente, dal suo punto di vista di designer e architetto, com’è evoluto e com’è oggi il rapporto tra industria e designer?
Rispetto alla generazione di mio padre è cambiato il contesto storico. Ai suoi tempi c’erano meno designer che di fatto erano architetti. C’erano inoltre meno industrie in un periodo, quello del dopoguerra, in cui c’era molto da fare e aleggiava un forte influsso dalla Scandinavia tradotto in arredi dalle linee semplici e pulite con legni chiari. Di base però, la vera svolta la dava l’industria che era disposta ad assumersi dei rischi appoggiando queste idee nuove. Allora la collaborazione fra il potere decisionale e mente creativa era veramente stretta; mio padre lavorava direttamente con Cesare Cassina. Adesso i processi produttivi sono molto più complessi, l’intero sistema lo è. Pensi solo che nel dopoguerra per testare i giunti di una sedia la si buttava dal tetto della fabbrica. Se non si rompeva, poteva andare in produzione. Quello che spesso avviene è che un’idea controcorrente ma di valore perde le sue caratteristiche di novità lungo la strada perché diluite in troppi processi decisionali. E questo si traduce in cose che molto spesso si assomigliano e sono più blande. Ai tempi non esisteva il marketing, o comunque esisteva in modo implicito, non era una scienza ma lo si faceva in modo intuitivo. Oggi invece con mercati più grandi e rischi finanziari maggiori, bisogna capire a quale pubblico ci si rivolge, diventando più mirati e discriminatori quando si sviluppa un progetto.
Questo processo più macchinoso incide anche sulla scelta delle finiture e del colore?
Senz’altro. I colori sono ciclici. Penso a quelli che prediligeva mio padre, il verdone British Racing Green, ad esempio: un colore diffusissimo negli anni Ottanta che ora sta tornando in auge dopo decenni per una generazione che lo percepisce in modo diverso. La scelta del colore è influenzata da quello che avviene intorno a noi; a mio avviso il primo input arriva dal mondo della moda, che ha cicli molto più rapidi rispetto agli altri ambiti; dalla moda assorbiamo i macro trend, siano essi ispirati alla natura o alla tecnologia, ma anche dal clima sociale e politico. Le scelte cromatiche sono un altro fattore che può richiedere investimenti importanti, perché aggiungere o modificare un colore può essere impegnativo in termini di miscele e stampi. In questo senso a volte vengono fatte anche scelte più conservatrici, di colori che comunque hanno riscontro, come il bianco, il nero e i neutri. Al contrario, si vedono emergere tinte forti e aggressive come i dayglow (fluo), arrivate al design e ai mobili dalle attrezzature sportive e dagli apparecchi elettronici. Ritornando agli interni, la scelta di colori e finiture dipende molto dalla tipologia e dal luogo di un progetto: una selezione di colori può essere adatta ad esempio a New York, ma assurda se trasferita a Miami e viceversa; bisogna sempre tenere in considerazione le differenze dettate dal contesto culturale, dal clima e dalla luce.
E ora uno sguardo al futuro, secondo lei quali sono i trend in fatto di finiture che vedremo nei prossimi anni?
Trovo molto interessante il fatto che ogni azienda ormai abbia in catalogo la riedizione di un grande maestro. Il motivo, secondo me, visto il tempo in cui viviamo, è la necessità di avere delle certezze. I pezzi iconici sono quelli sopravvissuti al test di decenni, sono quelli in grado di darci un senso di sicurezza, sono ancóre. Questi oggetti hanno un valore non solo economico, ma anche culturale e affettivo; un valore che nei nuovi prodotti non si riesce ancora a individuare. Da un punto di vista ambientale, oltre al vintage che può essere considerato una moda, sta prendendo sempre più piede il mercato dell’usato: un buon modello di economia circolare e di sostenibilità, che punta alla scelta di cose che durino nel tempo. La vera sfida oggi è trovare altri modelli di crescita che ci consentano di garantire benessere a tutti, senza dipendere da un’economia basata principalmente sul consumo di prodotti che esauriscono le nostre risorse.