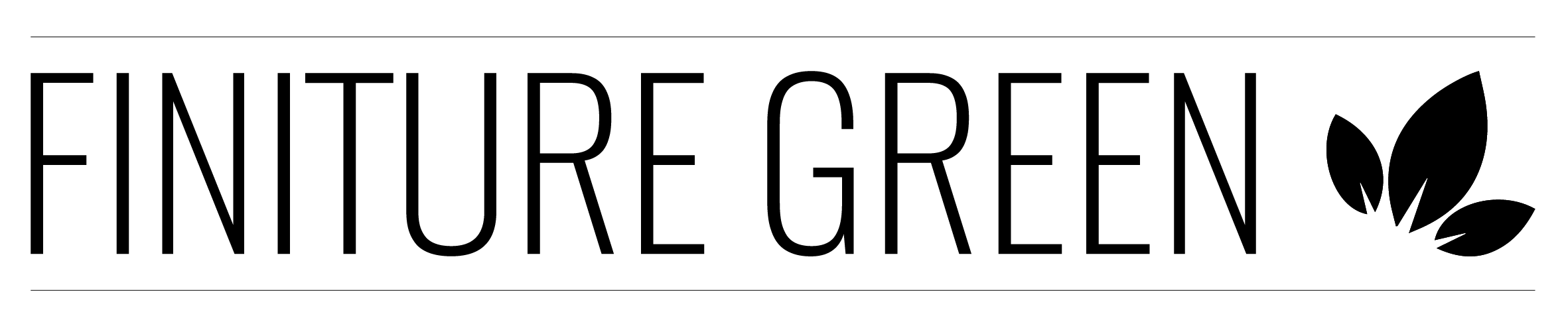I colori del cibo
La luce come ingrediente
I colori, sappiamo bene, ci danno la possibilità di distinguere e apprezzare ciò che ci circonda e soprattutto quel che si mangia.

Un’arancia non ha bisogno di chiedere supporto al colore per farsi presentare anzi è proprio il colore stesso a rappresentarla. Non ci verrà mai in mente di chiedere di che colore sia fatta un’arancia piuttosto utilizzeremo il nome del frutto per indicare il colore portato da un oggetto: un abito color arancia!
Forma e colore si fondono nello stesso elemento. È il caso in cui la forma assume identità attraverso il colore. Una fragola non ha bisogno di dichiarare il suo colore. Ma se partiamo dal colore, attribuirgli anche la forma, vuol dire dargli la specifica che lo fa distinguere.
C’è da chiedersi allora cosa intendiamo quando esiliando il colore dalla forma e cosa di esso riusciamo a distinguere in questo esercizio.
Quando intendiamo giallo, verde, rosso e blu, sappiamo bene che ci riferiamo ad una omologazione linguistica più che ad una realtà tangibile. Alle domande del tipo: Di che giallo si tratta? A quale giallo ti riferisci? La risposta immediata avviene per abbinamento. Giallo oro, ad esempio. Oppure se è per il Verde, al Verde foglia, Rosso fuoco, Blu mare ecc.
È facile dedurre che il colore non è mai da considerare come elemento isolato, ma anche che sia sempre in relazione. Questo ne dà la sua fondamentale caratteristica implicita, quasi sempre gravemente trascurata e data per scontata nella pratica, ossia la sua dipendenza. Le condizioni di confronto cambiano e si combinano a seconda se si considera il colore in riferimento alla materia o alle sue superfici, alla luce o alla mente che lo percepisce. (Pastoureau, M., 2019)
La mente che lo percepisce di quale cultura è stata nutrita per essere in grado di definirlo? Proprio nel caso del nutrirsi e quindi del cibo che la cultura gioca variazioni di significato a seconda dell’epoca a cui si riferisce. Lo scenario concettuale che supporta un certo tipo di visione ha molta incidenza nonostante si possa pensare che un’arancia resti sempre di colore arancione anche al cambio di epoca.
È noto come Paul Gauguin nel suo “Natura morta con arance” (1881) impieghi il frutto marcandolo soprattutto con la monocromia del colore più che con la sua caratterizzazione formale. Colore per il colore. Non occorre la forma per conoscerne il significato. Queste arance sono così vive nel colore tanto che la forma che ne destina l’identità del frutto, viene sottintesa.
Le arance di Gauguin sono tutte nelle pennellate di colore arancione. Ciò che oggi a noi risulterebbe una scena domestica, una ciotola con frutti di stagione, un riquadro di una scena comune in un ambiente comune destinata a documentare la bontà di quelle arance mature tanto da mettere appetito, altro non era al tempo di Gauguin che un’esibizione di potere, un simbolo d’opulenza. Le arance, infatti, in quel momento storico rappresentato parlavano dell’esotico a cui Gauguin era molto legato. Al tempo le arance non erano frutti usuali e di largo consumo. Erano considerati al pari dei frutti esotici e quindi se inseriti in dipinti di ambienti domestici volevano evidenziare la ricchezza e la prosperità della famiglia committente il dipinto. Questo è ancora un altro esempio di come colore e forme sono ad interpretazione del supporto culturale che li legge.
Il colore è sempre colore di qualcosa. A maggior ragione, il colore appartiene ad una forma in modo indelebile se colore e forma si fondono in un significato sovrastrutturale che ne diventa simbolo.
Le mele di Magritte sono tutte di uno specifico verde mela. Nella “La chambre d’écoute” (1958), addirittura il frutto invade tutta la stanza. Non c’è posto per altro. Lo spazio è saturo ed è pieno dalla presenza della mela che è quasi la cornice o il contenitore di quello specifico verde che più di ogni altro verde si addice allo stereotipo della forma che rappresenta, nell’immaginario collettivo, la mela come simbolo.
Qui la mela è nella pianezza della sua rappresentazione. Eppure, il titolo del quadro non parla della mela. L’ascolto che Magritte vuole in questa camera lo ottiene dagli occhi e non dall’udito. La stanza è così piena che non può contenere nessun suono. Nessun movimento è possibile. Non è solo la mela ad essere ingombrante ma è quel verde a prendere tutto il posto. L’invadenza totalizzante di quel verde è ferma sul concetto di relazione forma e colore che abbiamo già in mente quando nominiamo una mela. Si dirà che non tutte le mele sono verdi e che ce ne sono anche di rosse …gialle … con varie gradazioni. Ma allora perché Magritte sceglie il verde e proprio quel verde lì?
È sicuramente un verde che fa i conti con l’epoca in cui a quel verde il senso comune attribuiva quasi nell’ovvietà un concetto di natura primigenia. Un frutto nel pieno del suo vigore. Una mela giovane, piena di sostanza e tutta presente nelle sue potenzialità di essere frutto capace di cambiare il destino degli umani, basti ricordare cosa sia successo ad Eva. Quindi l’autenticità della forma della mela viene garantita dalla demarcazione del colore che ne esalta il grado di potenzialità del significato. Eppure, Magritte in questo dipinto vuole rappresentare il rapporto spazio e suono. L’accento ricavato dal titolo è posto sulla mancanza di sonorità in quello spazio surrealmente occupato dalla mela gigante.
Situazione assurda quanto fattibile a seconda che sia uno dei due elementi in gioco ad adattarsi all’altro. Se si parte dalla dimensione della mela, sarà stata la camera ad essere realizzata su misura e per quanto noi si possieda già la dimensione convenzionale di una stanza, quella ci parrà sicuramente molto molto piccola. Avviene tutta una percezione contraria se si parte dalla dimensione della camera. La mela risulta di dimensione impossibile per qualsiasi sforzo d’immaginazione. Difficilmente si riesce a tollerare un rapporto così sproporzionato tra le parti. Allora mela verde o meglio questo verde mela diventa icona di significati di rimando o trova la sua forza rappresentativa nella vocazione appetibile che sottintende? In altri termini è la rappresentazione stereotipata della mela al massimo del suo vigore plastico riconosciuta tale dalla convenzione, oppure è il verde a suggerire la mela del peccato in quanto rappresenta in sé l’immaturità del frutto e l’immaturità dei due progenitori della razza umana nel compiere il gesto proibito? È ben risaputo quanto siamo abituati ad abbinare certi sapori al colore dei cibi e come sia il colore a influenzare il sapore percepito. (Delwiche, J., 2004)
Sicuramente al tempo di Magritte il verde scelto per quella mela dipinta è selezionato non solo perché fornisce nozioni primarie di cultura sacra ma anche per le indicazioni anch’esse primarie che l’esperienza coeva dava come reazione a percezioni negative. Quel verde diventa per i contemporanei del tempo un segno di allerta coma a dire: se la mela è verde il sapore non sarà apprezzabilmente gustoso. Sarà aspro e quindi amaro. Sarà da evitare nello scegliere la mela. Quel verde corroborato dall’esperienza pratica della quotidianità più che dalla percezione culturale diventa segnaletico. Garantisce solo la forma ma non il sapore. La forma quindi anche attraverso la percezione cognitiva riferita all’esperienza diventa stereotipo, convenzione, forma che dipende dal colore per essere collocata in un contesto di significati omologati al valore di simbolo invece di percezione sensoriale. Per ottenere questo ci aveva ben lavorato Caravaggio nel realizzare sua la famosa “Canestra”. Lì l’appetito non può mancare. Quella frutta nella cesta è gustosissima forse anche eccessivamente matura se sulla mela sono visibili le ammaccature del frutto morbido che evidenziano il suo stadio di maturazione, indizio di un sapore dolce, succoso.
Se la “Camera d’ascolto” di Magritte si rendesse libera del tempo in cui è stata generata e si disponesse a dialogare con la contemporaneità, tutto ciò che per Magritte è stato racchiuso in quella mela verde e in specifico in quella tonalità di verde, sicuramente potrebbe essere interpretato come rappresentazione della vocazione salutistica che l’alimentazione di oggi sta sempre di più ricercando. Quel verde da segnale di allarme, da sensazione di amaro, di acre sarebbe totalmente capovolto. La raffigurazione anche se scostante al gusto oggi potrebbe essere interprete del benessere salutistico della dieta contemporanea. Potrebbe essere un incentivo o una testimonianza del tempo capace di essere simbolo più facilmente dell’aspetto edibile piuttosto che di quello di frutto proibito per antonomasia. Questa ricerca di significato porta in sé il peso notevole che il tempo stabilisce tra colore, forma e interpretazione simbolica che risente fortemente delle fluttuazioni culturali del tempo in cui si riferisce e dà la testimonianza di quanto l’educazione e la cultura percettiva del colore possano dare risultati diversi non solo cambiando contesto ambientale, ma anche ordine temporale.
Una mela verde oggi non riporta sicuramente di primo acchito al frutto proibito o al gusto acre, acerbo che il colore suggerisce del frutto così come era più facile avere ai tempi di Magritte. Oggi, anche se son passati pochi decenni, una mela verde è più indice di nutrimento salutistico che altro.
LA LUCE COME INGREDIENTE
“L’appetito vien mangiando” recita un detto popolare, ma anche il colore del cibo ha la sua incidenza anche notevole. La gustosità di un alimento, prima di essere apprezzata dalla bocca, è sicuramente intercettata dagli occhi che in una frazione di secondo ne profilano la gradevolezza o meno che potrà risultare al palato. Si tratta quindi di coadiuvare i caratteri effettivi dell’espressione del colore per permetterne di godere di quel che risulta scaturire dalla percezione diretta e di questo farne esperienza. L’assaggio avviene prima con gli occhi e poi con il palato. Questo è risaputo. Tuttavia, viviamo un tempo in cui si assimila molto di più dalle convenzioni culturali piuttosto che dalla percezione messa alla prova dal confronto con il reale. Una delle convenzioni da sfatare è quella della diffusa persuasione che esista il colore vero delle cose. Capita spesso di assistere ad uno spiccato accanimento nel rincorrere la riconoscibilità del colore secondo la sua veridicità (Mirzoeff, 2015).
La salvezza è inequivocabilmente legata alla possibilità di averlo sotto la luce giusta: quella naturale, quella del sole. Anche in questo caso, in preda a grossolane convinzioni non ci accorgiamo che è proprio la luce del sole quella più variabile e oscillante che esista. Solo che scorre lentamente e il suo cambiamento è rilevante solo sulla lunga distanza. Quindi saper gestire indoor la luce naturale dall’alba al tramonto permette di avere un rapporto di efficacia tra la percezione al naturale che abbiamo degli ambienti e delle superfici rispetto alla incidenza della luce stessa in ambienti chiusi.
Questa condizione di modulazione della luce rispetto all’efficacia della comunicazione di veridicità dei colori soggetti a illuminazione artificiale, si verifica facilmente esaminando il rapporto colore e luce in riferimento al cibo. Il colore influenza l’intensità del sapore percepito, ma ci serve anche per l’identificazione del cibo, una operazione esclusiva e fondamentale che il nostro cervello fa quando ha di fronte qualcosa che deve essere ingerito.
Un succo di arancia, ad esempio in riferimento a quanto citato sopra, ci si aspetta che sia conseguente al colore della buccia del frutto. Se assume il colore blu è più difficile da identificare e quindi da accettare come vero. Sappiamo bene che il colore naturale dell’arancia e del suo succo è l’arancione. La conseguenza si esprime con un disgusto o rifiuto non solo nell’accettare di bere quel succo ma anche con uno scollamento identitario rispetto alla relazione di appartenenza: il succo blu non è dell’arancia quindi non corrisponde a verità. Non si tratta solo di mancata corrispondenza, ma soprattutto di disattesa aspettativa.
Come conciliare, allora, la funzionalità della percezione ottica con la cultura che la traduce in una percezione cognitiva? Occorre dare il più appropriato possibile accento di luce al colore. Se per gli ambienti la luce può risultare un collante di tutto lo spazio circostante, per il cibo può esserne un ingrediente.
Ogni alimento ha il suo carattere, ogni colore ha una propria identità.
La scelta di una luce appropriata per il cibo significa restituire una percezione veritiera di quel che ci si aspetta da esso. Infatti, combinando una buona resa cromatica e una temperatura colore ci si avvicina a una luce naturale, si riesce ad evidenziare le caratteristiche cromatiche di appartenenza delle sostanze che il nostro cervello ritiene per esperienza commestibili e attraverso la buona distinzione del colore ne attribuisce il valore del gusto: dolce o salato, acre o piccante, maturo o acerbo, cotto o crudo. Una luce non corrispondente, una resa cromatica alterata, possono cambiare l’idea di ciò che si sta osservando e di conseguenza far precipitare l’esperienza gustativa e olfattiva. Fatte queste considerazioni, alla luce tocca molta responsabilità nel tener di conto l’adeguamento ai canoni culturali per determinare l’allineamento tra percezione retinica e percezione sensoriale dei colori.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE CON GLI EFFETTI DELLA LUCE SUL COLORE DEL CIBO
Il rapporto luce e colore in riferimento alla genuinità dei cibi è stato il tema di alcune ricerche progettuali condotte allo Smart Lighting Lab dell’Università di Firenze che dirigo. Nel corso di questi ultimi anni alcune sperimentazioni hanno permesso di realizzare lampade studiate appositamente per analizzare l’influenza della luce sulle scelte a tavola.
I risultati sono stati sorprendenti. Abbinare la luce al cibo si è dimostrata una vera e propria perizia alchemica che ha avuto modo di aprire un ampio confronto tra limiti oggettivi della percezione e le pregiudiziali culturali che sul colore incidono nella nostra società più incline ai luoghi comuni che alla garanzia dell’esperienza. La luce è stata così associata ad ingrediente della pietanza da portare in tavola e la tavola il set più idoneo ad ospitarne il raccordo tra gradevolezza e genuinità in connubio con sapore e gusto del piacere, del piacer di stare a tavola e il benessere nutrizionale.
La luce infatti influenzando la cromia degli alimenti permette di indirizzare o alterare l’aspetto invitante delle pietanze. Da qui la necessità di studiare il giusto equilibrio della genuinità del colore rispetto alla comunicazione che rende. (Russo, V., 2017)
Queste lampade sono progettate per creare la giusta corrispondenza tra l’autenticità della cromia della pietanza in rapporto alla cromia della luce. Il giusto equilibrio tra i due modulato dall’intensità e dalla temperatura della luce che permette di ottenere genuinità visiva prima ancora che olfattiva e gustativa del piatto che si ha davanti.
Quando nel 1981 Gualtiero Marchesi con il suo risotto oro e zafferano divenuto un must, un simbolo, un’icona della gastronomia stellata da chef-artista, pone molta attenzione a come far visionare la sua pietanza esponendola sotto la luce giusta.
La delicatissima foglia d’oro, che lui ripone sul risotto, non deve essere solo delicata nello spessore, nel sapore ma anche brillante e “dorata” al punto giusto per gli occhi in modo da esaltare la pietanza e non abbagliare lo spazio sottostante dei chicchi di riso su cui si appoggia.
CONCLUSIONI
L’affermazione di Marchesi “ogni piatto ha la sua luce”, intende esprimere la volontà che i colori di ogni pietanza non debbano essere distorti da luci, ma ognuno di essi ha la necessità di essere esaltato da una luce appropriata. Un aspetto scenografico può risultare distensivo, accogliente, invitante ma anche contribuire a creare l’effetto sorpresa, che stimoli la curiosità all’assaggio. Occorre progettare la luce in grado di togliere pregiudizi di allerta che si possano avere affidandosi al solo colore degli alimenti e dare supporto ad avvicinarsi al gusto gradevole attraverso lo stimolo avuto dal piacere visivo. Al contrario se una luce deforma le aspettative visive del colore di una pietanza o distoglie la corrispondenza del colore alla gustosità dall’alimento, il rischio è di alterare la gradevolezza e di svilire il sapore atteso dal commensale e voluto dallo chef della pietanza. Oggi è la tecnologia dei led che permette tutta questa attenzione e offre svariate modulazioni di possibilità per ottenere il massimo del risultato voluto e apprezzato nel calibrare la corretta emissione di luce adatta alle cromie del cibo.
L’esclamazione “mangiare con gli occhi” dà già di per sé la disponibilità all’attitudine sinestetica dell’esperienza. Nel caso del cibo, la voglia di conoscere in anticipo ciò che portiamo alla bocca, trova nel colore degli alimenti e nella appropriatezza della luce, l’invito a disporre il gusto a curiosare tra le intersezioni e i rimbalzi tra colore e sapore.
Come abbiamo visto, allo stimolo ad aver un buon appetito con spontaneità occorre associare molto altro che specifichi e renda il comportamento umano più consapevole nel fare scelte più accorte a livello nutrizionale. Le potenzialità sono tutte da esplorare anche attraverso il far esprimere le capacità del colore ad essere tramite nel trasferire la corrispondenza della propria genuinità a quella che vorremmo per le nostre scelte alimentari e non solo.
Referenze | Bibliography
- Alfarano, G., “Ipertrofica immediatezza. Da Instant City a Instagram, il progetto nella società delle immagini”, Rivista AND, vol. 38, 2020
- Alfarano, G., Spennato, A., “Educate to wellness by the emotion of light”. in: Electronic Imaging & the Visual Arts, Firenze University Press, 2019
- Delwiche, J., (2004) “The impact of perceptual interactions on perceived flavor”, in «Food Quality and Preference» vol. 15
- Gombrich, E. H., (1960), “Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation”, trad. di Federici, R.,(1965); Collana Saggi n.354, ed. Einaudi
- Konrad, F., (1887)“Der Ursprung der künstlerischen Tätigkeit ” trad. it., L’attività artistica, trad.di Sgorlon, C., (1963) ed Neri Pozza
- Malaguzzi, S., (2013), “Arte e cibo”, ed Giunti -FI
- Migliori, N., (2012) “La materia dei sogni”, ed. Contrasto, Roma
- Mirzoeff, N., (2017) “Come vedere il mondo”, ed. Johan& Levi
- Pastoureau, M., (2010), “Croma”, ed Contrasto
- Pastoureau, M., (2019), “Un colore tira l’altro”, ed Ponte alle Grazie
- Pearson Spence, C., (2017), “Gastrophysics: The New Science of Eating”, ed. Viking
- Rossi, M., (2012) “Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari”, ed.Maggioli
- Russo, V., (2017), “Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing”, ed. My lab
- Xie, Y.; Sha, Z.; Yu, M., (2008), “Remote sensing imagery in vegetation mapping: a
review”, Journal of Plant Ecology